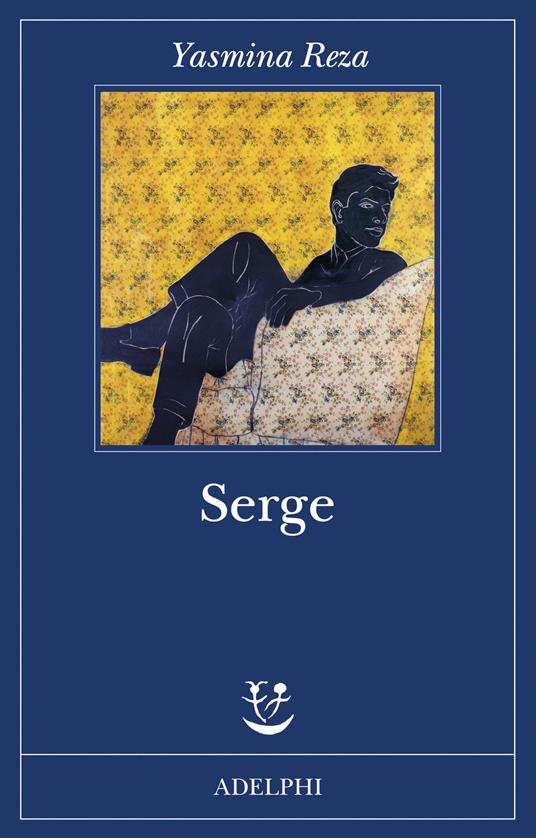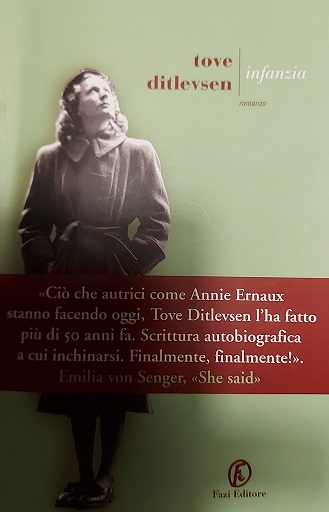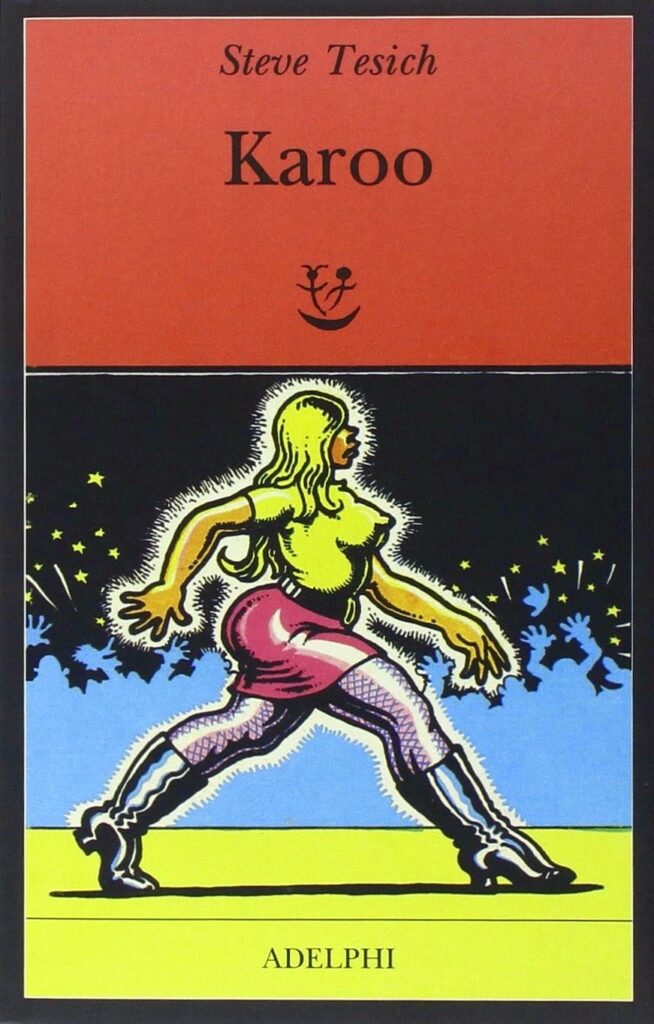
“La vita non appare priva di significato, semmai ne è così ricca che il suo significato deve essere costantemente ucciso per il bene della coesione e della comprensione”.
Ci sono romanzi che si limitano a raccontare vite, più o meno reali. Poi ci sono romanzi che raccontano la Vita, anche quando i protagonisti appaiono lontani, non solo geograficamente, dal lettore. È il caso di “Karoo” il romanzo postumo di Steve Tesich (mancato nel 1996), pubblicato negli Stati Uniti nel ’98 e in Italia da Adelphi soltanto nel 2014.
Steve Tesich, serbo naturalizzato statunitense, sceneggiatore, premiato con l’Oscar, drammaturgo e scrittore, ci regala un personaggio disturbante, a tratti sgradevole e odioso, ma fortemente umano. Saul Karoo, disgustosamente ricco, grazie alla propria abilità di “scribacchino”, è consapevole di non essere un artista. Da tempo ha messo da parte il sogno di scrivere un proprio romanzo, tuttavia a Hollywood è lo “scriptor doctor” più ricercato e retribuito, perché riesce a trasformare un film (anche di grande valore artistico) in una pellicola da botteghino.
Saul è consapevole dei proprie manchevolezze e dei propri limiti , sia professionali che personali, ma come un inetto si lascia vivere, preferendo la continuità di un’esistenza, comunque triste e deludente, piuttosto che rimediare agli errori ben noti. Fino a quando non accade qualcosa che lo spinge a diventare artefice del proprio destino, ma che lo rende (novello Ulisse) colpevole di Hybris, perché non è possibile decidere per gli altri. Anche quando si tratta delle persone amate e si vuole agire per la loro felicità.
Con leggerezza, solo apparente, però, e ironia per mezzo di “Karoo” Steve Tesich ci racconta la vita con il suo carico di illusioni, delusioni, sogni irrealizzati, errori, vigliaccherie, egoismi (l’elenco potrebbe proseguire, ancora, ma non voglio togliere al lettore il piacere della scoperta, né risultare tediosa).
Fino alla tragedia che l’autore abilmente lascia intravvedere nel corso della narrazione, insinuando un sospetto che il lettore vorrebbe scoprire infondato e che condurrà anche ad altro, ad un dolore che non concede vie di fuga né riscatto.