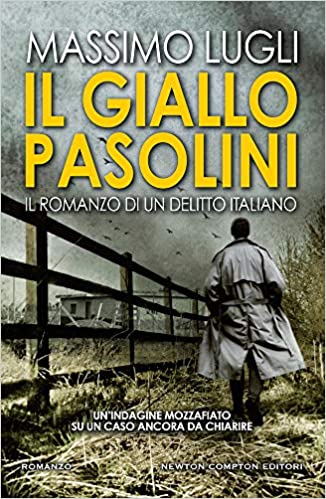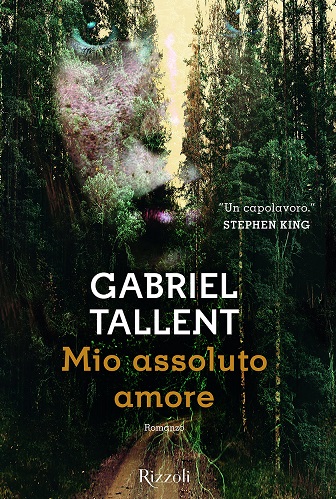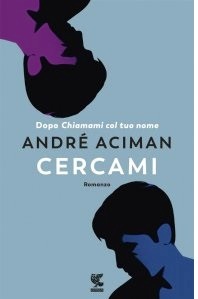
Cercami di ANDRÉ ACIMAN
Diciamolo subito, è un romanzo che parla di amore. Di amori incontrati all’improvviso e inaspettatamente; di amori lasciati andare, ma attesi per anni; di amori cercati e trovati, apparsi come eterni, ma fugaci; di amori che sono rimasti sospesi, ma che non potranno mai diventare realtà.
Samuel, un vecchio professore in pensione, una mattina sale su un treno a Firenze diretto a Roma per tenere una conferenza e trascorrere del tempo con il figlio Elio, giovane promettente musicista. Davanti a lui, si siede una giovane donna, Miranda, con il suo cane di compagnia che infastidisce Samuel il quale cerca rifugio nel libro che si è portato dietro, ma che non riuscirà a leggere perché lei comincerà a parlargli. Durante il viaggio l’anziano professore e la giovane donna si racconteranno dando così inizio ad una storia d’amore che diventerà compiuta ed adulta. Nonostante il “Tempo”, distanza impietosa che separa i due: Samuel è consapevole che Miranda ha più o meno l’età di suo figlio, ma la passione e l’amore che legherà i due non può essere frenata dall’età.
“Tempo” è il titolo della prima parte del romanzo dove la voce narrante è proprio Samuel il cui sguardo ci porta in giro per Roma e ci fa scoprire l’intensità della passione che in meno di dodici ore lo legherà a Miranda.
“Cadenza”, “Capriccio” e “Da capo” sono i titoli delle altre tre parti in cui si articola il romanzo che, di fatto, è il sequel di “Chiamami col tuo nome” nel quale Andé Aciman raccontava l’amore tra due uomini, Elio e Oliver.
Elio, figlio di Samuel, oramai affermato pianista e Oliver, professore universitario a New York prossimo, padre di due figli al College, racconteranno le loro vite rispettivamente in “Cadenza” e “Capriccio” per poi ritrovarsi in “Da capo”, nuovamente estranei e incapaci di riportare indietro il tempo.
Perché il tempo è impietosamente traditore e non può ridare mai indietro quanto abbiamo lasciato andare e quando pensiamo di potere riacciuffare quello che non siamo riusciti a portare a compimento rischiamo di essere delusi.
Sarà così anche per Elio e Oliver o i due uomini avranno costruito qualcosa, loro malgrado e nonostante le loro scelte?
Scrive ad un certo punto Aciman: “Il fatto è che la magia di una nuova conoscenza non dura mai abbastanza. Alla fine vogliamo sempre chi non possiamo avere. Sono quelli che abbiamo perso o che non hanno mai saputo della nostra esistenza a lasciare il segno. Gli altri ne sono solo una misera eco”.
Ma è veramente così? È questo il messaggio che vuole lasciarci l’autore? Personalmente (e invito i lettori ad avviare la discussione, se e quando lo riterranno opportuno) ritengo di no: anche perché la storia d’amore tra Samuel e Miranda chiude in maniera circolare il romanzo e lascerà un segno concreto in un piccolo Oliver, frutto del loro amore.