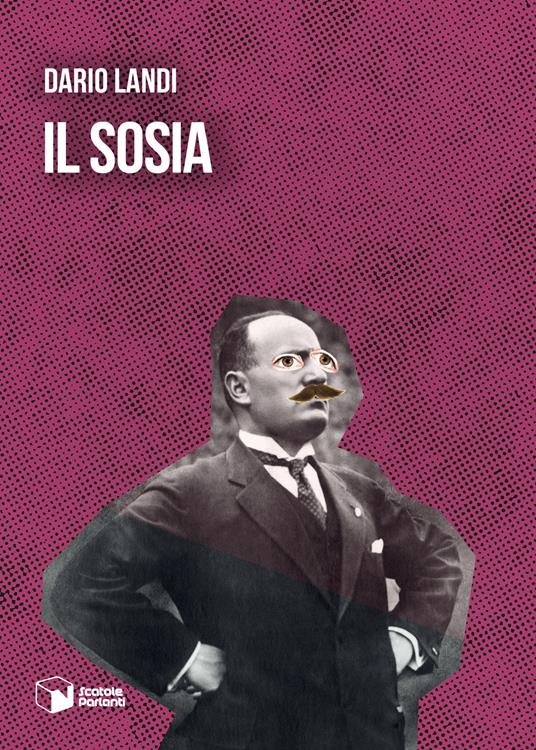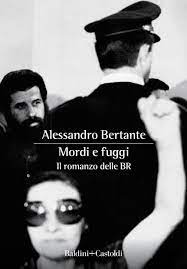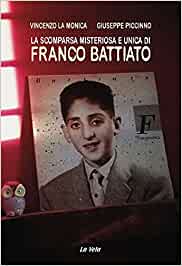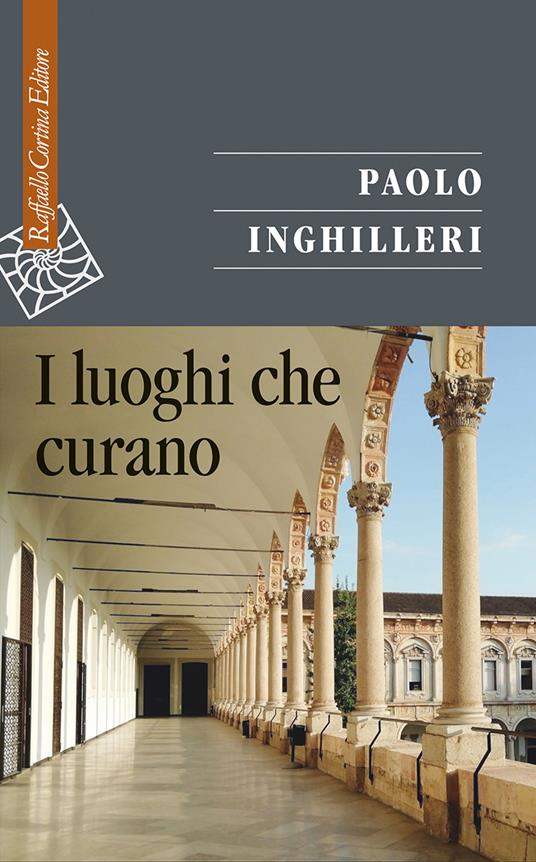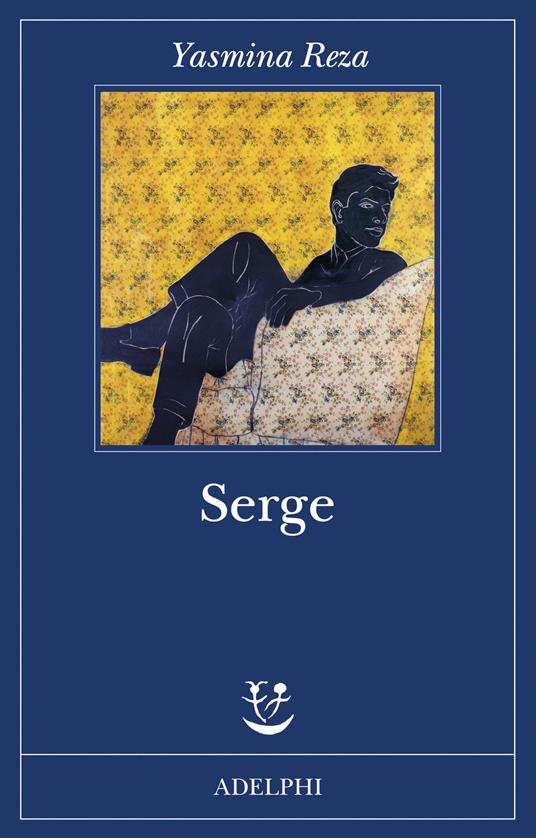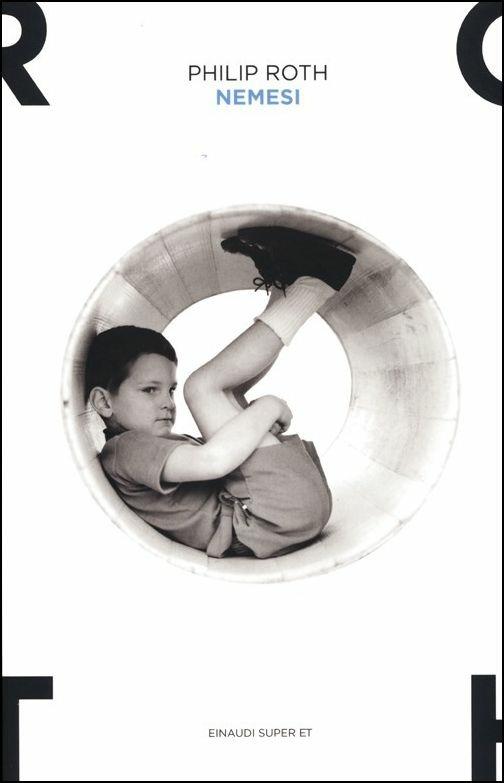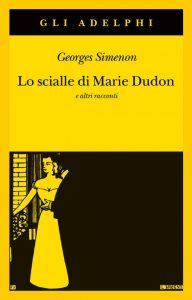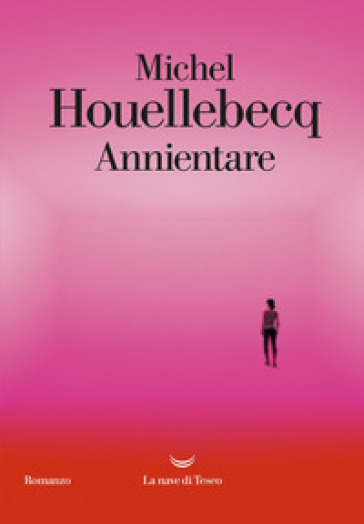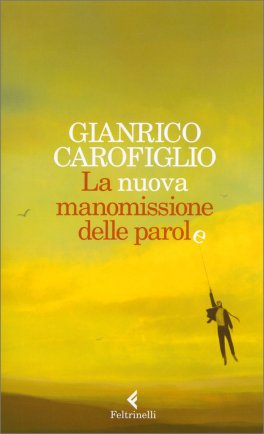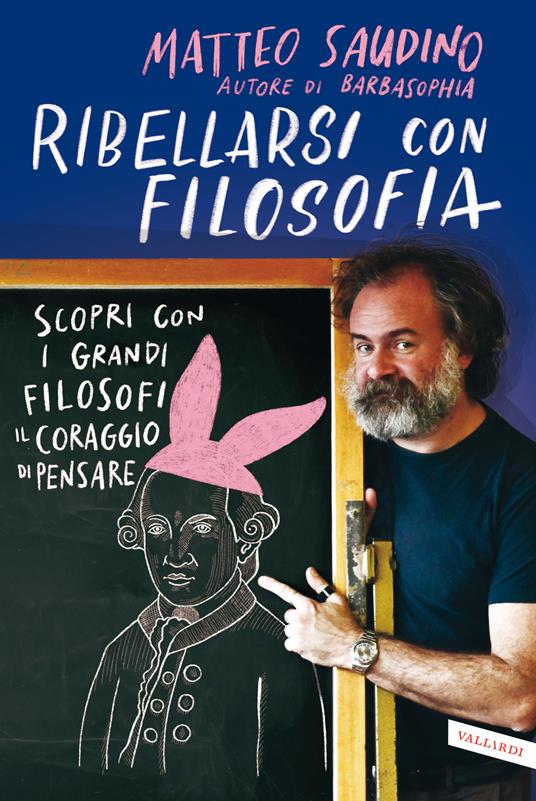
“La filosofia è un inarrestabile viaggio di crescita individuale e collettivo, al termine del quale potrebbe sorgere in noi il desiderio di diventare artefici del nostro destino” (pag. 22)
Primum esse, deinde philosophari. Il vecchio adagio latino dovrebbe diventare la stella polare della nostra epoca in cui molti sedicenti maestri, complici anche i social network che danno a chiunque la possibilità di esprimersi su tutto, si ergono a lettori critici, pronti a philosophari, manifestando, però, il vuoto umano e culturale di cui sono portatori. Per essere filosofi, però, bisogna prima essere e per essere è necessario conoscere, abbracciare un Sapere che non è mai finito, che è sempre rimesso in discussione, secondo l’insegnamento di Socrate: so di non sapere. Unica certezza data all’uomo saggio che ricerca la verità. Una certezza che, oggi più che mai, epoca di sofisti del nulla, come dicevamo, sarebbe veramente rivoluzionaria e porterebbe alla Filosofia, intesa come conoscenza e studio, secondo l’insegnamento degli antichi filosofi che furono astronomi, filosofi, matematici, geografi… ricercatori e portatori di conoscenza e per questo temuti dal potere che li perseguitarono e ne decretarono la morte. Come Ipazia, Anassimandro, Epicuro, Olympe de Gouges, Marx alcuni dei filosofi di cui il prof. Saudino ricostruisce la vicenda umana e il pensiero nel suo volume di indubbio successo, considerate il numero di edizioni già date alle stampa.

durante l’interessante e partecipata conversazione sul suo libro
che ho avuto il privilegio di presentare.
Il successo del Prof. Saudino e, naturalmente, della Filosofia potrebbe sembrare una contraddizione visto che , secondo il detto popolare che l’autore ha ben presente, la filosofia è quella cosa con la quale o senza la quale tutto rimane tale e quale. Parole che sembrano perfette per una società super tecnologica, nella quale sembrano prevalere le scienze applicate, dove bisogna produrre, dove le multinazionali promuovono progetti finalizzati a distruggere la scuola del sapere nel nome di una scuola di competenze che in maniera altisonante sembrano talora orientati a distruggere la Conoscenza che rende liberi e sviluppa il Libero Pensiero (oltre alle competenze!).
Sostenere che la filosofia non serve a nulla è, da parte del Prof. Saudino, ma anche della vostra lettrice, una provocazione perché tutti noi siamo coscienti del fatto che la Filosofia oltre ad essere “ il sapere più nobile”, – come già aveva detto Aristotele – rende veramente liberi in quanto (sono queste le meraviglie che ci vengono rivelate nella prima parte del libro) serve a creare problemi, a fondare scelte, immaginare altre realtà, criticare il potere, prepararsi a morire, interrogarsi sulla vita. Insomma, ci rende Uomini e ci distingue dai bruti, perché solo l’Essere Umano, per quanto sappiamo ad oggi, è capace di interrogarsi, conoscere, avere consapevolezza di sé e del mondo.