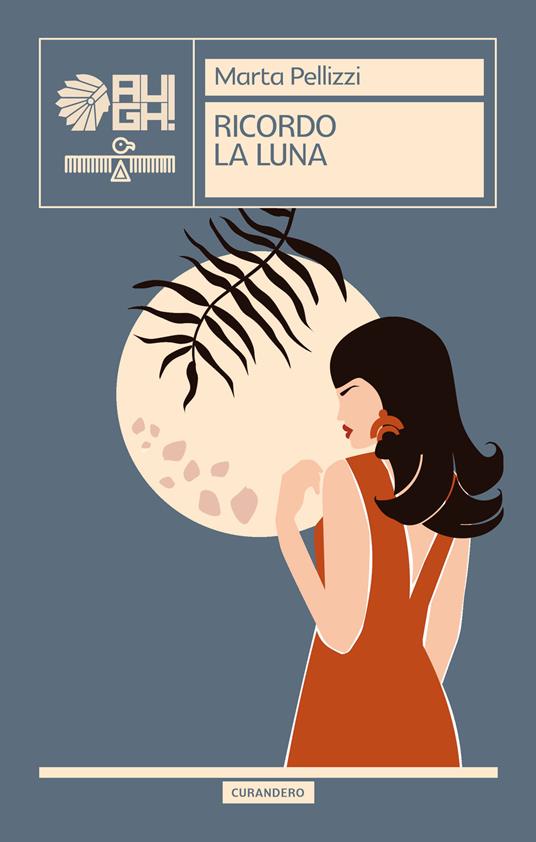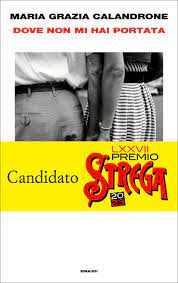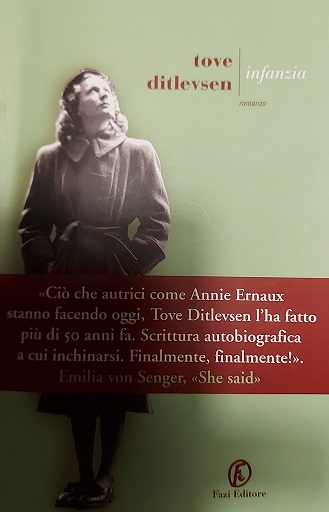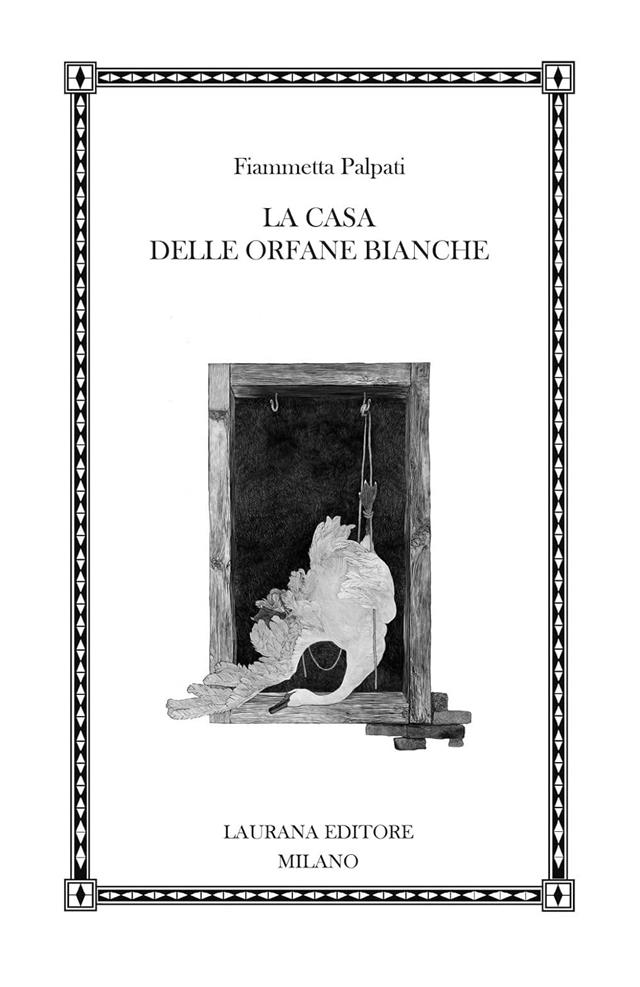
“Benedette figliole. Benedette fanciulle con le lenti da vicino e le vene varicose, possibile che non capiate? Le orfane bianche siete voi. Voi siete davvero orfane bianche” (pag.225)
Natàlia, Lucia e Germana sono tre donne non più giovani che fin dalla prima infanzia sono state private delle cure materne. Le rispettive madri, infatti, per motivi affini (il disagio psicologico, in qualche caso emerso dopo il parto, che le ha rese figlie delle loro figlie) hanno delegato ad altri, mariti, sorelle, parenti, l’accudimento delle tre bambine, rendendosi protagoniste di atti di rifiuto, talvolta reiterati, che – come scopriremo nel corso della lettura – avrebbero potuto avere conseguenze gravissime. Al dramma dell’abbandono si sono aggiunti dolori e perdite personali, sconfitte e delusioni eppure Natàlia, Lucia e Germana, non più giovani ma nonancora anziane, non hanno rinunciato al sogno di avere del tempo per sé, da vivere lontano, pur per brevi periodi, dalle rispettive madri di cui sono costrette ad occuparsi. Si tratta, com’è facilmente immaginabile, di relazioni tossiche, condizionate dal disamore accumulato nel corso degli anni, difficili da gestire e, apparentemente senza soluzione.
Fino a quando Lucia non propone alle due amiche, ritrovate dopo anni, di vivere tutte insieme, con le rispettive madri, nella sua grande casa e condividere le responsabilità dell’accudimento:
“Un incastro perfetto, considerato tutto.
Una società.
Un sodalizio.
Di più: un gioco” (pag. 29)
Le sei donne (le tre figlie di mezza età e le madri anziane) iniziano la loro convivenza che seguiremo attraverso la narrazione per quaranta giorni: da un mercoledì (18 febbraio, le ceneri) a una domenica (5 aprile, Pasqua di resurrezione). La narrazione, pardon la rappresentazione di un lungo percorso quaresimale sarà seguita dallo sguardo attento e scrutatore di uno spettatore esterno: perché l’autrice, utilizzando in maniera sapiente e originale la scrittura, mette in scena personaggi, situazioni, sentimenti quasi fosse un dramma teatrale dove il comico e il tragico convivono, come sempre accade nell’esistenza quotidiana, per raccontare vite spezzate che imparano a ricomporsi, rapporti conclusi che possono ricominciare, affetti negati che si scoprono. Succede anche nella vita. Perché questo è la letteratura: la vita che diventa parola e che, attraverso la parola, si sublima.
Perché accada, però, è necessario scoprire verità e errori e comprendere come porvi rimedio. È necessario imparare ad accogliere e ad incontrare. È necessario sapere perdonare e perdonarsi, come per le nostre donne.
“Il perdono è nell’incontro.
L’uno fa un passo: chiede perdono. L’altro fa un passo: dà il perdono. Un dono più grande.
Il perdono è nell’incontro – nel passo in avanti, e non solo nel gettarsi in ginocchio. Ma anche chi perdona fa un passo verso l’altro, e si getta in ginocchio. Chi chiede perdono e chi dà il perdono sono sullo stesso piano, possono allungare una mano e si toccheranno. Usano i medesimi gesti. Conoscono gli stessi nomi. Essi chiamano male il male, e bene il bene. E tutto questo, coscienza”. (pag.309)