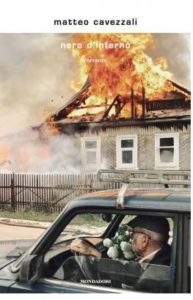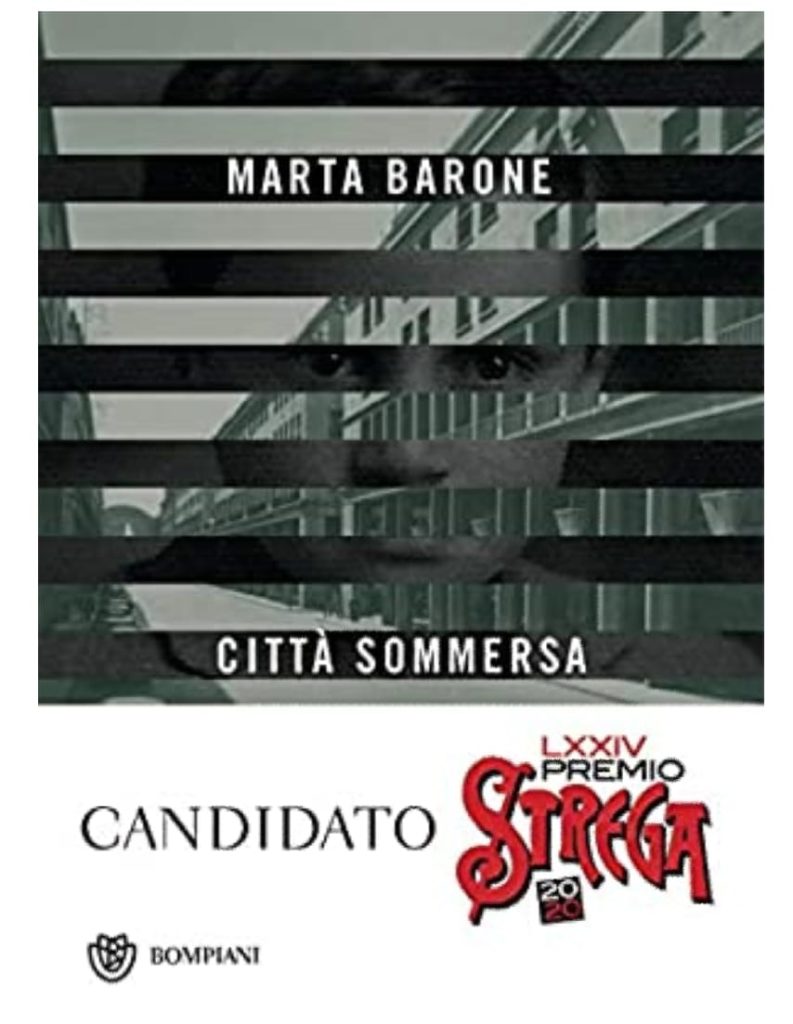
I libri (certi libri) sono come le persone (alcune persone, fortunatamente, non tutte): si presentano carichi di promesse, lasciano intravedere importanti prospettive future, ma alla fine lasciano una sottile scia di delusione.
È il caso di “Città sommersa” – proposto per concorrere all’ultima edizione del Premio Strega – che affronta gli anni difficili di lotta politica, inseguendo il sogno socialista, culminata nel terrorismo.
La ricostruzione di quegli anni è affidata alla protagonista, giovane donna non ancora trentenne, lettrice di romanzi per una casa editrice, che sogna di diventare scrittrice, ma deve fare i conti con un blocco che non riesce a superare. Fino a quando, dopo la morte del padre, davanti a domande rimaste senza risposta sulla vita di un genitore, scopriremo, misconosciuto, avverte l’esigenza di sapere perché “a un certo punto i morti tornano a cercarti, e ti devi sedere al tavolo con loro”.
Marta si ritrova tra le mani un documento relativo ad un processo subito dal padre Leonardo come presunto affiliato a Prima Linea, evento che ne ha cambiato la vita, la vita di un giovane uomo militante che l’autrice non ha mai conosciuto, di cui ignora il passato. Spinta quindi dal bisogno di apprendere (e comprendere) si lancia alla ricerca di documenti e testimonianze, contattando le persone che con lui hanno condiviso un percorso umano e politico in cui il sogno utopico di una società senza sfruttatori né sfruttati veniva strumentalizzato dai capi di un’organizzazione che dalle pagine della Barone appare spietata e opportunista.
Marta scopre così che il padre Leonardo aveva sacrificato la propria giovinezza per “servire il popolo”, aderendo ad un movimento che, però, finiva per stritolare i propri adepti:
“Annullarsi, cancellare la propria identità era un passo quasi obbligato:
non si potevano avere sensazioni proprie, come predicavano gli opuscoli,
o si sarebbe perso di vista il fine buono, il fine vero,
il vago ideale di felicità per tutti i viventi
che avrebbero obliterato i mali del mondo”.
Il romanzo permette di conoscere la disillusione di molti giovani militanti le cui scelte anche personali sono state imposte dai vertici del Pcim, partito di estrema sinistra. In particolare, per Leonardo Barone il disinganno diventa insopportabile dopo l’arresto e l’isolamento subito da parte di coloro che aveva considerato compagni di strada. Al punto che arriva a dichiarare di avere sbagliato tutto e di avere sprecato la propria vita. Una amarezza che Marta scopre troppo tardi, quando è oramai impossibile rimediare ai silenzi e alle incomprensioni che hanno caratterizzato il suo rapporto col padre.
Senza dubbio “Città sommersa” ha il merito di approfondire una delle pagine più tormentate dalla storia dell’Italia degli Anni Settanta, offrendo al lettore, soprattutto se, per ragioni anagrafiche, non ha vissuto quegli anni con consapevolezza, diversi spunti di riflessione.
Tuttavia, la narrazione mostra delle falle nell’uso della lingua che, a tratti, appare ambiziosa: accade quando la Barone, che generalmente utilizza un linguaggio medio, lascia scivolare vocaboli eccessivamente ricercati e aulici, fuori contesto con la scrittura complessiva. Un esempio per tutti: “fatagione” che troviamo nel terzo capitolo a cui, dopo poche righe, fa seguito “che leggiucchiai in modo disordinato nei mesi dopo”. (Successivi, forse avrebbe giustificato l’eleganza di fatagione, che starebbe per incantesimo o magia) Ambizioso appare, poi, il richiamato allo “smaliziato lettore” il quale (proprio perché smaliziato) non può non sentire un’eco manzoniana. Si avverte , dunque, da parte dell’autrice una certa ansia di prestazione che, a nostro modesto avviso, non serve al romanzo.