
Immaginate che qualcuno vi offra un braccialetto super tecnologico, forse esteticamente non particolarmente avvincente, ma capace di interagire con la parte più profonda del vostro essere, suggerendovi di lasciare perdere durante una discussione che sta alterando il vostro umore o segnalandovi il negozio da cui è possibile ricevere sulla porta di casa i vostri biscotti preferiti, in un formato extrafamiliare e scontatissimo. Aggiungete a ciò che questo braccialetto super tecnologico è in grado di indicare un piano alimentare e di fitness che vi permetta di tornare in forma, giovani (almeno nello spirito) e scattanti, pronto a segnalarvi eventuali eccessi che potrebbero compromettere il risultato raggiunto.
Aggiungete ancora che l’uso di tale braccialetto super tecnologico vi consenta l’esonero dal ticket sanitario e l’accesso a negozi esclusivi da cui uscire senza passare dalla cassa: l’acquisto sarà registrato dal vostro monile avveniristico e prontamente addebitato sul vostro conto.
Probabilmente, qualcuno, forse tra i più pigri, dirà che non sarebbe male.
Altri, probabilmente più maliziosi, si chiederanno quali sarebbero le condizioni per avere accesso a così tanti privilegi.
Sono proprio questi ultimi a porre l’attenzione sul tema del romanzo di Rielli il quale, attraverso la confessione del protagonista, Marco De Sanctis, ci offre un’analisi spietata del tempo che stiamo vivendo prospettando una società futuribile, senza dubbio distopica, ma che (come è accaduto con altri romanzi distopici) rischia di diventare profetica.
Marco De Sanctis scopre che con la sua laurea in Filosofia difficilmente potrà entrare nel mondo del lavoro. Potrebbe tentare con l’insegnamento, ma le liste di attesa sono lunghe e potrebbero trascorrere dei decenni prima di potere conquistare una cattedra. Decide, pertanto, di sfruttare la propria cultura e l’abilità narrativa inventando un blog satirico che, in breve, ottiene un notevole successo. Uno spazio virtuale attraverso il quale denunciare il “male che le macchine, i computer, gli algoritmi stavano facendo all’umanità”.
In breve tempo, però, Marco De Sanctis entra a far parte proprio di quel mondo da cui si sentiva estraneo (si definiva addirittura un luddista!) e fonda una startup, la Before, un’azienda di Big Data, capace di prevedere il comportamento di milioni di consumatori, grazie alla quale si ritroverà ricchissimo, senza però arrendersi (anche se in alcuni momenti potrebbe sembrare il contrario) alla realtà digitale, a quel mondo virtuale che ci vorrebbe tutti burattini manovrabili, senza cultura, né senso critico, cieche e obbedienti pecorelle, pronte a seguire a capo chino il capo branco.
Perché è questo quello che si vede sulle piazze virtuali che tutti, oramai, frequentiamo, mettendo in mostra la nostra vita e pronunciando sermoni su argomenti di cui non sappiamo nulla. Perché nella società del digitale non contano né conoscenze, né competenze. Un concetto che Rielli ha ben chiaro:
“Come lo spieghi a un bambino che cresce e che vede che l’insulto è senza conseguenze, che il merito non conta un cazzo, tantomeno il lavoro, il farsi il culo, l’appassionarsi a un progetto, il sapere qualcosa. No, solo l’odio, la superficialità, nessun senso di giustizia”.
Chi scrive sa, per professione, che quanto appena citato ha solide fondamenta: purtroppo, la convinzione che l’impegno e lo studio, rigoroso e approfondito, servano a ben poco, visto che tutto è disponibile (hic et nunc) su internet, è sempre più radicata. E, ahinoi, non solo tra i giovani con scarsa voglia di impegnarsi! Quei giovani educati, sul modello di molti adulti, a inseguire bisogni mimetici che non potranno mai soddisfare. Quei giovani che, magari seguendo le indicazioni di un capo popolo, attribuiranno la responsabilità del fallimento alla vittima di turno da sacrificare sull’altare di un dio senza nome. Non è dunque un caso che il protagonista faccia sua la lezione dell’antropologo René Girard le cui teorie ispirano il “Documento strategico Before” che chiude il romanzo.


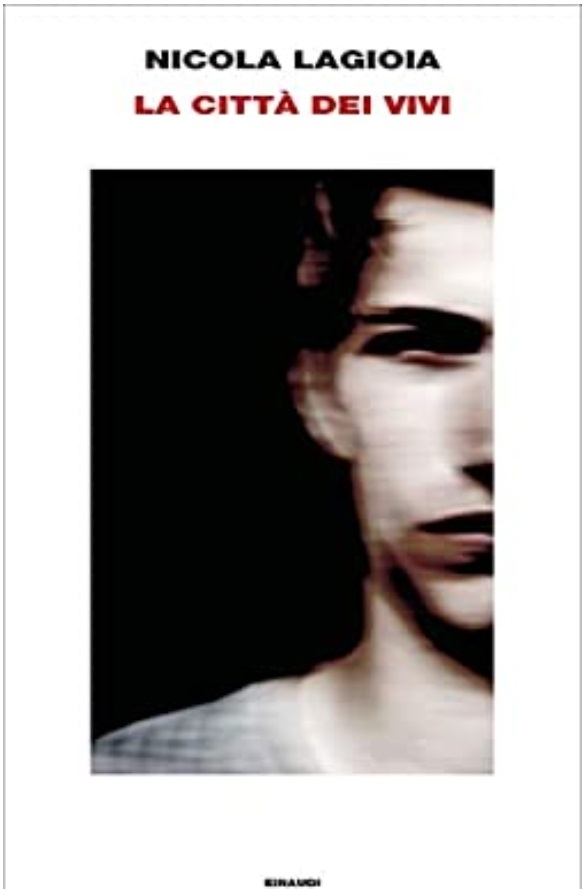



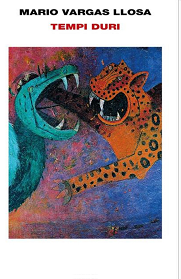


 A Tutto Volume)
A Tutto Volume)

 A Tutto Volume)
A Tutto Volume)
