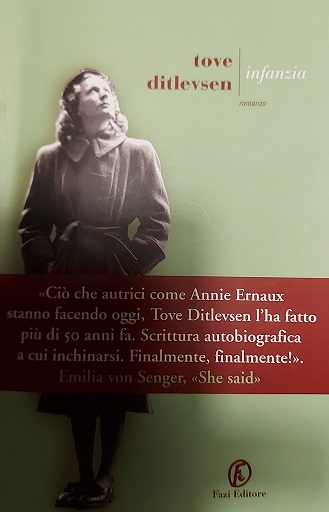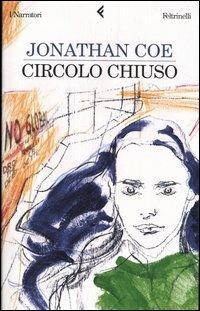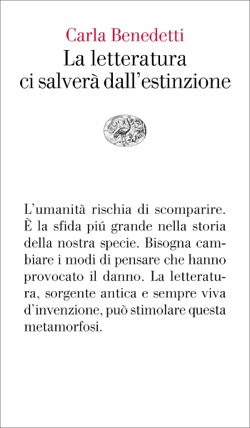L’autore, appena venticinquenne, fa il suo ingresso nel mondo letterario con un romanzo che, come nelle favole della tradizione, ha come protagonisti gli animali, con i vizi, le virtù, i sentimenti degli uomini. Disperati e speranzosi; appassionati e crudeli; devastati dalla vita, ma capaci di guardare oltre e reinventarsi; sognatori e realisti proprio come gli uomini. I personaggi di questa storia sono faine, cani, maiali, tassi, ricci, volpi che allegoricamente ci rappresentano e ci dicono cosa siamo e cosa possiamo essere.
L’io narrante e protagonista è una faina, Archy: il padre è stato assassinato da un umano che lo ha sorpreso a rubare, lasciando la moglie e i figli nella disperazione di un inverno che rende difficile, se non impossibile, cacciare. Il bisogno lascia poco spazio all’amore materno e agli affetti familiari, consumati dalla necessità di sfamare la nidiata, trascurando, chi particolarmente debole, sembra avere poche possibilità di sopravvivenza.
Così, quando, Archy, cadendo da un albero nel tentativo di portare a casa delle uova di uccello, rimarrà zoppo, sarà ceduto dalla mamma alla vecchia volpe usuraio. Ha inizio per Archy la sua nuova vita, il primo di tanti cambiamenti che caratterizzeranno la sua esistenza:
“La vecchia volpe decise di insegnarmi tutto quello che sapeva”.
In poco tempo, nonostante i maltrattamenti, Archy diventa l’apprendista della volpe che, intuendo di essere oramai alla fine della propria vita, desidera un erede a cui lasciare i beni accumulati in anni di usura violenta. In particolare, però, la volpe insegna ad Archy a scrivere, a leggere ed interpretare un libro, il Libro, una bibbia rubata negli anni della giovinezza.
Alla lettura della bibbia la volpe ha dedicato parte della propria vita, convincendosi di essere “un figlio di Dio” e decidendo di raccontare la propria esperienza, una vita di rapina e violenza con cui fare i conti, prima di superare la soglia dell’esistenza per andare verso un oltre di cui non si ha consapevolezza.
Il romanzo, così, supera i confini della favola, per diventare un libro sulla scrittura, su questa capacità, tutta umana, che ci rende “figli di Dio”, regalandoci l’eternità, come dice Archy:
“mi fece riflettere sul potere della scrittura, quanto fosse immune al tempo”.
Per cui, oramai, vecchio, stanco e solo, disperatamente solo, Archy decide “che l’unico compromesso prima di sparire era raccontarmi”, fino a scoprire il potere taumaturgico della scrittura:
“Più scrivo, più l’ossessione della morte si fa leggera.
La sconfiggo ad ogni pagina, specchiandomi nel colore, nelle linee che traccio.
Dio porterà la mia anima chissà dove, disperderà il mio corpo nella terra,
ma i miei pensieri rimarranno qui, senza età, salvi dai giorni e dalle notti”.
Affiderà il suo racconto autobiografico, insieme con la bibbia avuta in dono dalla volpe, al suo ultimo amico, Klaus, come un tesoro prezioso, da tenere sempre con sé:
“Ti diranno tante verità, ti faranno male,
ma non potranno mai ingannarti su quello che sei,
su quello che siamo”.